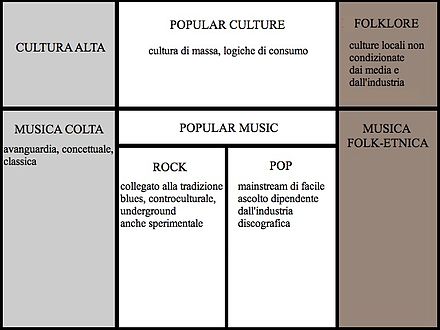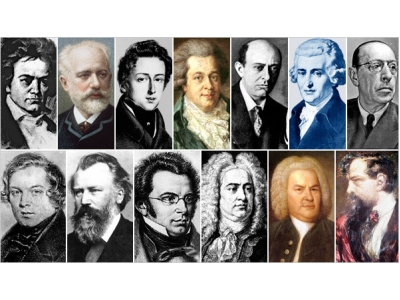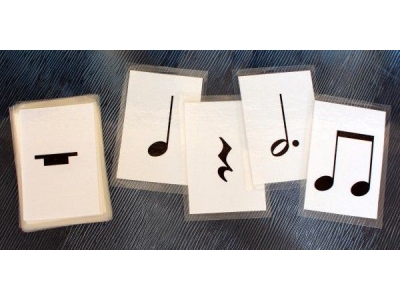Agli studenti che si spostavano da un’università all’altra dell’Europa è attribuita la larga diffusione che ebbe nel Medioevo la poesia goliardica. Con i loro canti, essi animavano le feste del carnevale, in cui regole e tabù erano provvisoriamente aboliti. I più noti sono i Carmina Burana (che significa Poesie di Beuren), cioè quel gruppo di trecento canti, prevalentemente anonimi, scritti in latino, tedesco, francese, tra il XII-XIII secolo, e ritrovati, nel 1803, nel monastero benedettino di Benediktbeuren, presso Monaco di Baviera.
Alcuni testi della raccolta, tra cui, ad esempio, quello intitolato Oh Fortuna, sono stati musicati nel 1937 dal compositore tedesco Carl Orff (1895-1982) per coro e orchestra, ma in origine la loro musica aveva le caratteristiche tipiche di molti canti medievali, sillabica, monodica e accompagnata da semplici melodie di strumenti tipici.
Quello che potete ascoltare è proprio Oh Fortuna: si tratta di un inno goliardico che canta un tema molto sentito da questi giovani quello della Fortuna, o meglio, della Sorte, del Fato. Le parole spiegano come la sorte da favorevole possa diventare avversa, e come comandi su qualunque elemento.
Il brano è eseguito dagli studenti di seconda media con tastiere, metallofoni, xilofoni e flauti.